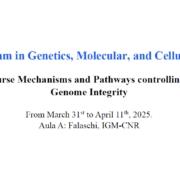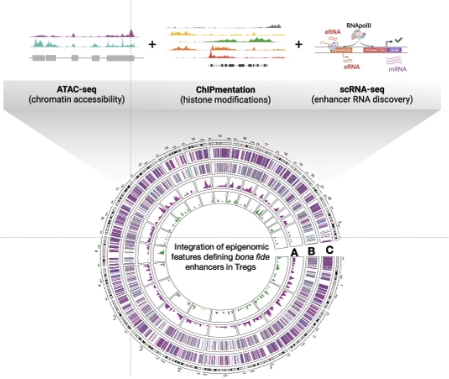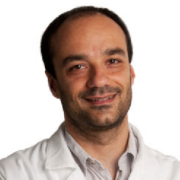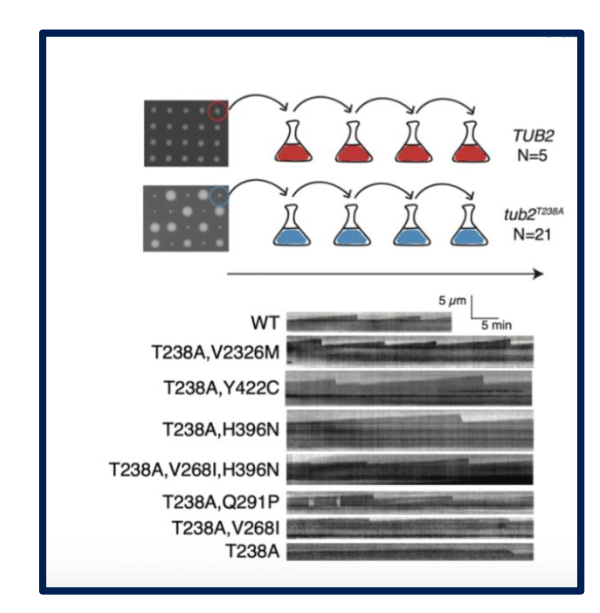È scomparso nel tardo pomeriggio di sabato 22 marzo 2025 il prof. Giovanni Maga, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, già direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare “Luigi Luca Cavalli-Sforza”. Aveva 59 anni.
La vita di Giovanni Maga è stata profondamente intrecciata con quella del nostro istituto, presso il quale ha iniziato a lavorare già durante il percorso di laurea, cui sono seguiti il master e la specializzazione. Successivamente al postdoctoral fellow, svolto presso l’Università di Zurigo, Maga ha proseguito la sua carriera presso l’istituto di Pavia; dapprima come assegnista di ricerca, poi come ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca e responsabile della Sezione Enzimologia del DNA & Virologia.
Nel 2019 è stato nominato direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare.
Ha mantenuto la direzione fino al 2023, quando ha assunto la guida del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR.
Nel corso della sua carriera è stato autore di oltre 200 articoli su riviste internazionali, di libri anche divulgativi e di diversi brevetti.
Giovanni Maga si è occupato di enzimologia della replicazione del DNA sin dalla laurea. La sua ricerca si è concentrata sulla caratterizzazione dei sistemi enzimatici coinvolti nel metabolismo dei nucleotidi e nella duplicazione del materiale genetico nelle cellule umane e nei virus. Il suo interesse ha riguardato la comprensione dei processi molecolari di base sia sull’individuazione di nuovi bersagli enzimatici per la chemioterapia antivirale e antitumorale. Ha studiato i meccanismi biochimici che collegano la replicazione e la riparazione del DNA nelle cellule tumorali, con particolare attenzione alle DNA polimerasi specializzate, e le interazioni molecolari tra ospite e virus per sviluppare farmaci antivirali ad ampio spettro.
Tutti noi dell’Istituto di Genetica Molecolare siamo profondamente addolorati per la perdita di Giovanni, scienziato, collega, e amico.
Partecipiamo sentitamente al dolore dei suoi cari.